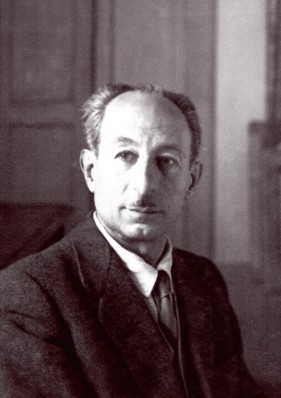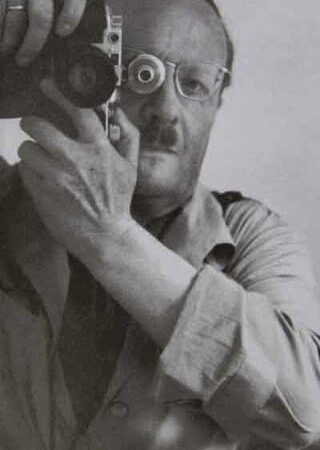Questo tappeto musivo, caratterizzato da un disegno policromo, è formato da una serie di semicerchi che si uniscono a un tondo centrale, racchiuso in una cornice a treccia semplice bicroma. Al suo interno, si alternano motivi geometrici e figurativi tipici della produzione tardoantica, come animali, uccelli e cornucopie, con al centro una testa di Medusa dal caratteristico aspetto orrido, simbolo di protezione e avvertimento.
Un altro aspetto interessante di questo mosaico è la sua storia travagliata. Il mosaico, lungo circa 3 metri e largo 1,50, fu il primo ritrovamento archeologico ufficiale nel territorio di Foggia e segnò un momento significativo per la cultura locale. Durante la demolizione delle case per la costruzione di un nuovo palazzo nel centro di Lucera, i lavori furono interrotti dalla Regia Udienza e informato il Re Ferdinando IV. Il mosaico venne successivamente donato al Re da Pellegrino, che sperava di ottenere il permesso per proseguire i lavori. A causa di problemi tecnici, ci vollero mesi prima che il mosaico fosse trasportato al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, grazie all’intervento di maestranze provenienti dalla zona vesuviana.
Oggi, finalmente, questo magnifico mosaico tardoantico è esposto nelle nuove sale del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che ospita uno straordinario patrimonio della Magna Grecia. Tuttavia, un’ulteriore curiosità riguarda il fatto che, nel catalogo dedicato alla collezione, il mosaico viene talvolta erroneamente attribuito alla città di Pompei, piuttosto che a Lucera. La sua storia avvolta nel mistero e il lungo percorso che lo ha portato a Napoli ci ricorda l’importanza di salvaguardare e valorizzare il nostro patrimonio, per poterlo finalmente apprezzare nella sua terra d’origine.
Per chiunque desideri ammirarlo, il mosaico di Lucera oggi fa parte di un insieme di straordinarie opere provenienti da Canosa, Ruvo, Metaponto, Taranto, Cuma, Nola e Paestum, creando un tributo di bellezza senza pari alla cultura della Magna Grecia.